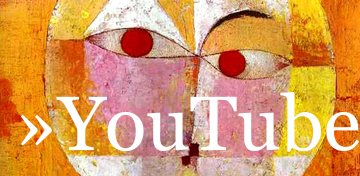Alzare lo sguardo, poi sorvolare, o guardare a terra?
di Alberto Magnaghi
Gli interessi della politica e della finanza globale sono sempre più stellarmente lontani dai mondi e dai luoghi di vita, soprattutto da quando come scriveva André Gorz nel 1981 “ogni politica… è falsa se non riconosce che non può esserci più la piena occupazione per tutti e che il lavoro dipendente non può più restare il centro dell’esistenza, anzi non può più restare la principale attività di ogni individuo”.

Appunti per chi si occupa di sviluppo locale
di Franco Mario Bisaccia Arminio
1.
Vivere nel luogo in cui sei nato, nella casa in cui sei nato, è una cosa rischiosa. È come giocare in fondo al pozzo. Si nasce per uscire, per vagare nel mondo. Il paese ti porta alla ripetizione. In paese è facile essere infelici. I progetti di sviluppo locale devono tenere conto di questo fatto: non li possono fare da soli i rimanenti, perché in paese non c’è progetto, c’è ripetizione. È difficile essere innovatori. In genere ognuno fa quello che ha sempre fatto, giusto o sbagliato che sia. Se nella pasta ci vogliono due uova piuttosto che una, comunque tutti continueranno a usarne due. E chi beve non troverà nessun incentivo a smettere. E chi si guasta lo stomaco mangiando troppo continuerà a mangiare troppo. Ci sono due abitanti tipici, il ripetente e lo scoraggiatore militante. Spesso le due figure sono congiunte, nel senso che lo scoraggiatore è per mestiere abitudinario, non cambia passo, continua a scoraggiare, è appunto un militante. Più difficile essere militanti della gratitudine, della letizia. È come se la natura umana in paese fosse più contratta, non riuscisse a diluirsi. E si rimane dentro un utero marcito.
Bisogna arieggiare il paese portando gente nuova, il paese deve essere un continuo impasto di intimità e distanza, di nativi e di residenti provvisori. Questo produce una dinamica emotiva ed anche economica. E la dinamica è sempre contrario allo spopolamento: bisogna agitare le acque, ci vuole una comunità ruscello e non una comunità pozzanghera.
Bisognava aprire emotivamente i paesi, dilatare la loro anima e invece la modernità incivile degli ultimi decenni li ha aperti solo dal punto di vista urbanistico, si sono sparpagliati nel paesaggio, a imitazione della città, ma è rimasta la contrazione emotiva. Il paese va aperto tenendolo raccolto. Lo sviluppo locale si fa ridando al paese una sua forma, ricomponendolo, rimettendolo nel suo centro, ma nello stesso tempo c’è bisogno di apertura. Lo sviluppo lo può fare chi lo attraversa il paese con affetto, non chi ci vive dentro come se fosse una cisti, un’aderenza, un cancro.
Spesso i paesi più belli sono quelli vuoti, come se fossero uccelli svuotati dello loro viscere. È come se la parte viscerale del paese fosse quella più malata, quella più accanita a tutelare la sua malattia. Un’azione di sviluppo locale allora deve essere delicata ma anche dura, deve togliere al paese i suoi alibi, i suoi equilibri fossilizzati, deve cambiare i ruoli: magari le comparse possono essere scelte come attori principali e gli attori principali devono essere ridotti a comparse. E allora non si fa sviluppo locale senza conflitto. Se non si arrabbia nessuno vuole dire che stiamo facendo calligrafia, vuol dire che stiamo stuccando la realtà, non la stiamo trasformando.
2.
I progetti di sviluppo locale negli ultimi anni non hanno dato grandi risultati, per questo è nata la Strategia Nazionale delle Aree Interne che nei prossimi mesi comincerà ad essere operativa in alcune Aree Pilota. Si cerca di cambiare logica rispetto alle fontane restaurate che sono di nuovo in disuso, alle piazze molte volte ripavimentate, ma mentre si posavano le pietre, gli abitanti di queste piazze posavano la loro vita al cimitero. E i ragazzi cercavano un Nord che non c’è più. Qui parlo di Sud, ma il tema dello spopolamento non è il tema del Sud, è il tema delle montagne. E allora ragionare di montagne vuole dire capire che spazio sono le montagne. Forse più che dello sviluppo, le montagne hanno bisogno della gioia. Nei progetti di sviluppo locale non si parla mai delle gioia. Lo sviluppo ha bisogno di schede, è inteso come un risultato alla fine di un processo. La gioia è intesa come qualcosa di intimo, di ineffabile. Forse è venuto un tempo in cui la gioia deve essere immessa nello spazio sociale come elemento cruciale. Anche salutare un vecchio è un progetto di sviluppo locale. Non ha senso lavorare a progetti in cui tutto si risolve in una dimensione monetaria. Il denaro tende a scendere a valle, non rimane sulle montagne. Lo sviluppo locale deve fecondare passioni. Se ti regalo una mungitrice e tu pensi alle Mercedes più che alla mucca, non ho risolto nulla. Se lavoriamo a un progetto per anni e non ci accorgiamo che un forno sta per chiudere vuol dire che stiamo facendo retorica dello sviluppo, vuole dire descrivere lo sviluppo senza darlo. È come accendere una candela in una grotta molto grande: le candele descrivono la luce, non la danno.
Non si può tollerare che un caffè costa molto di più di un uovo fresco. E un quintale di grano costa meno di un shampo dal parrucchiere. Il fuoco centrale dello sviluppo locale non può che essere la terra. È intollerabile che l’Italia importa un milione di vitelli. Dobbiamo mangiare la nostra carne, mangiarne poca, ma buonissima. I paesi devono produrre cibo di altissima qualità, i paesi vanno concepiti come farmacie: aria buona, buon cibo, silenzio, luce. E poi il soffio del sacro. Dove si è in pochi nessun cuore è acqua piovana. Ma bisogna immettere enzimi dall’esterno. Bisogna portare nelle montagne i pionieri del nuovo umanesimo. Più che mandare i soldi, bisogna trovare il modo di portare nei paesi e nelle montagne le persone giuste. E far rimanere le persone giuste. Allora un progetto di sviluppo locale ragiona di persone, non ragiona di progetti, i progetti vengono dopo. È molto discutibile questa logica che prima si fanno i progetti e poi si vede se c’è qualche persona che li può interpretare. A volte si fanno sceneggiature staccate dalla realtà. Come se nel film si potessero trovare delle scimmie al Polo Nord.
E poi c’è la questione del tempo. Un progetto di sviluppo locale non si elabora e poi si realizza. Bisogna cominciare, magari con un pezzo piccolissimo, e mentre si realizza qualcosa si continua a elaborare il progetto. Mentre immaginiamo come razionalizzare la sanità, intanto ripariamo le buche sulle strade.
Giustamente si dice che ci vogliono i servizi e ci vuole il lavoro, altrimenti la gente va via. Ma il rischio sono sempre le astrazioni. Ci sono servizi inutili e lavori che non servono a niente. Bisogna partire da chi c’è in un certo luogo e da chi potrebbe arrivare. E allora ecco che si ragiona su certi servizi e su certi lavori. Magari in un paese serve un barbiere, non serve un centro di documentazione per lo sviluppo locale.
Olivetti faceva lavorare nella sua fabbrica artisti e scrittori. E la sua fabbrica da un paese era diventata avanguardia mondiale. Forse quando parliamo di sviluppo locale sarebbe opportuno ripassarsi la lezione di Olivetti e la sua idea di comunità. Olivetti puntava sulle persone. L’Italia interna ha bisogno di persone, deve trovare e incoraggiare le persone che contengono avvenire. Capisco che ci vogliono strumenti, bisogna ingegnerizzare bene le questioni per evitare che restino sulla carta, ma non si può tollerare che mentre mettiamo a punto i nostri schemi le persone perdono fiducia, vanno via.

Eclissi della classe media, pochi i salvati tanti i sommersi
di Aldo Bonomi
E’ interrogante l’ultimo libro di Marco Revelli. Mi domando se non ci resti che sussurrare, o urlare “non ti riconosco più” e ritirarci in buon ordine nel racconto di microcosmi e di territori resilienti, magari facendo rete con Magnaghi e la sua rete dei territorialisti. Oppure se valga la pena di alzare lo sguardo e continuare a cercare per continuare a capire oltre l’invito di Candido “Dobbiamo coltivare il nostro orto”, evocato in un altro scritto di Marco sul Manifesto. O ancora se valga la pena continuare nella fatica di Sisifo dello scomporre e ricomporre il farsi della società nel salto d’epoca dell’accelerazione, con lo sguardo delle lunghe derive braudeliane del potere, del mercato e della civiltà materiale. Sono tempi di sorvolatori del mondo, di storytelling, di flussi che impattano nei luoghi mutandoli antropologicamente, culturalmente, socialmente ed economicamente.

Un passo per volta…verso la comunità “che viene”
di Federico Zappini
E’ interessante riflettere sul perché negli ultimi tempi la figura del camminatore – in politica, ma non solo – sia tornata di moda. Emmanuel Macron, sottraendosi alle primarie socialiste in Francia, ha scelto “En Marche” come nome del suo nuovo progetto. Un’invocazione di (e al) movimento, volutamente in contrapposizione all’immobilismo dei partiti tradizionali, visti come strumenti inutilizzabili e fuori dal tempo. Uno schema che sembra – per il momento e almeno nei sondaggi – funzionare. Sfruttandonela scia come un provetto ciclista Matteo Renzi ha lanciato la sua campagna congressuale nel tentativo di rimuovere il ricordo del suo triennio a Palazzo Chigi, non dinamico come nelle attese. Agendo di traduzione, materiale e spudorata, ecco nascere “In cammino”. Le piazze e le strade d’Europa si preannunciano quindi punteggiate di esploratori politici che sperimentano l’idea – non nuova, certo – che se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna a muovere il primo passo. Di fronte alla disarticolazione sociale e politica, per porre un argine allo sfarinamento dei corpi intermedi e rispondere alla crisi dei processi democratici torna centrale l’esigenza di stabilire un contatto diretto con i cittadini (con quel popolo a cui tutti si riferiscono e che nessuno sembra davvero comprendere) e di riaffermare una presenza capillare sul territorio. Peccato che in pochi sembrino interessati a ricordare e ridare corpo all’esperienza politica sperimentata da Alexander Langer, “Viaggiatore leggere” continuamente a scavalcodei confini europei e delle differenze culturali, capace di sguardo lungo e di traiettorie radicali.
Negli ultimi anni – anche sotto la potente spinta, nel bene e nel male, della tecnologia – il viaggio è tornato a essere elemento utile per interrogare il presente, mettere in evidenza storie esemplari, incrociare sguardi e sviluppare processi di conoscenza e apprendimento. Con risultati più o meno gradevoli ed efficaci. Attraverso percorsi più o meno onesti dal punto di vista intellettuale. Non si contano i libri e i siti che raccolgono best practises nei campi della sostenibilità e dell’innovazione (il più famoso nel nostro paese è probabilmente “L’Italia che cambia”). C’è chi – come Paolo Rumiz, Enrico Brizzi e Wu Ming – ha recuperato il genere letterario della narrazione di viaggio, meglio se a piedi e con andamento lento, restituendogli dignità e successo. Persino lo scalcagnato, ormai ex, direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano ha descritto in due libri gli itinerari di ricerca di coloro che, dentro la crisi economica, mettono in campo azione di resistenza imprenditoriale. Avrò certamente dimenticato qualcuno in questa rapida carrellata. Siamo di fronte – è evidente – a un “mercato” particolarmente segmentato e competitivo. Cosa differenzia quindi un viaggio come quello che ci apprestiamo ad iniziare da tutti quelli che l’hanno preceduto e da quelli che certamente lo seguiranno?
Si può partire carichi di certezze – sentendosi profeti piuttosto che viandanti, apolidi della politica – oppure leggeri, e in un certo senso fragili, sicuri solamente del fatto che dentro le trasformazioni epocali che stiamo osservando, a livello globale come locale, vadano cercate e condivise idee e ipotesi politiche capaci di riconoscere, articolare e promuovere cambi di paradigmi e non la difesa e la conservazione dell’esistente. “Non è il tempo della moderazione” scriveva Simone Casalini nei giorni scorsi dalle colonne del Corriere del Trentino, riflettendo attorno alla scivolosa categoria dei populismi e del fallimentare approccio della politica al montare di fenomeni d’insofferenza nei suoi confronti.
Il viaggio di sifr assume le caratteristiche di un’inchiesta collettiva e multiforme sulla modernità, contraddittoria e a tratti disturbante, così come – se vogliamo prendere un altro esempio letterario – l’ha descritta con grande profondità e acutezza Daniele Rielli nel suo “Storie dal mondo nuovo”, con la sola parziale eccezione dell’ultimo capitolo – non originale e curioso come il resto del libro – sul vicino Alto Adige. Allo stesso tempo, parlo in prima persona in questo momento, sifr è anche l’urgenza di lavorare sull’identificazione di uno scenario personale e collettivo che, per uno strano caso del destino, coincide con la lettura dell’ultimo romanzo di Paolo Cognetti “Le otto montagne”, storia che sento molto mia sia perché rappresentativa di una generazione confusa e alla costante ricerca di un’ancoraggio al futuro che per la capacità dell’autore di mettere in relazione le diversità umane (i due protagonisti, le loro esistenze) e ambientali (la città e la montagna) dentro un percorso accidentato e per nulla scontato di continue verifiche del passo successivo da compiere. E ancora – ultimo, ma non in ordine di importanza – sifr è il tentativo di spiegare che dentro la lunghissima transizione tra il “non più” e il “non ancora” – di cui ancora non vediamo la fine, anche e soprattutto per colpa nostra – quella da cercare non è la comunità “che fu” ma quella “che viene”. Una comunità che, nell’epoca dell’accelerazione come mantra, ragiona sulla necessità di darsi il tempo e di trovare il modo di stare insieme, restituendo valore all’incontro e alle relazioni. Una comunità che la politica, chi altrimenti, è chiamata ad accompagnare dentro le importanti sfide di questi “tempi interessanti”.
Ecco allora che questo cammino è guidato dalla curiosità e dalla voglia di lasciarsi stupire piuttosto che dal battere percorsi sicuri e avvicinarsi a mete conosciute. Non si accontenta di confermare un’idea di partenza ma si nutre di confronti sinceri e persino conflittuali. Non da (quasi) nulla per scontato, semplicemente perché non può permettersi di farlo, e pretende di mettere sotto stress ogni tema che incontrerà lungo la strada.


Alla ricerca delle lucciole
«Il viaggio a me sembra la forma d’intimità per eccellenza, forse perché consente il dialogo ma accoglie anche il silenzio: rispetta le solitudini, lascia spazio al discorso interiore e alla contemplazione. Il paesaggio che scorre cattura lo sguardo, è un pensiero condiviso. Così l’andare insieme assomiglia molto al vivere insieme: c’è un rapporto di coppia, un percorso più o meno accidentato, il tempo necessario ad arrivare in fondo»
Paolo Cognetti, “A pesca nelle pozze più profonde” (Minimum fax)
di Federico Zappini
(17 febbraio 2017) Se non fosse già stata usata in mille altre occasione si potrebbe far riferimento alla metafora biblica della traversata del deserto. Bene si adatterebbe alla solitudine da cui abbiamo deciso di partire, se non fosse che il contesto politico dentro il quale ci muoviamo non è caratterizzato solo da un’interminabile serie di vuoti (linguistici, valoriali, organizzativi) ma anche e soprattutto da un livello di saturazione (“l’abbagliante luce prodotta dalla modernità”, così come la descrive Huberman [1]) che opprime e che disorienta. Lo spazio della riflessione, dell’approfondimento, dell’analisi e del confronto – alla base di qualunque sistema politico e sociale che pretenda di funzionare – è oggi quanto di meno praticabile e accogliente si possa immaginare. Saturo appunto, in un mix letale di conformismo e indifferenza.
Ne scrive benissimo Ugo Morelli: «Noi tutti siamo saturi di informazioni che non riescono a farci avere un’idea di un problema o di un fenomeno e, confusi, ci dimeniamo nelle selve del presente. Si dimena pure il linguaggio della politica che, forse, è uno dei luoghi della massima saturazione. Lo svuotamento di significati del gergo pare una parabola inarrestabile e ogni tentativo di proporre una controtendenza è riassorbito e sepolto nella palude del già visto o del non senso». Eppure le forme della politicizzazione – come si tenta a volte, con eccesso di semplificazione, di argomentare – non sono venute meno, anzi. Solo assumono forme, nel bene e nel male, molto diverse da quelle che sappiamo riconoscere, che riteniamo legittime di essere prese in considerazione. La maggior parte di esse, almeno tra quelle che assumono maggiore evidenza mediatica, non riescono ad assumere funzione generativa e si accontentano (o addirittura rivendicano) la propria azione di freno, di rinserramento, di conservazione.
E’ dentro questo scenario che bisogna lavorare, almeno per cominciare, nei termini della ricerca, della curiosa osservazione. Vanno individuate le lucciole – sempre citando le preziose riflessioni di Huberman – che vedono dissipare la propria delicata luminosità nell’accecante bagliore dentro il quale sono costrette a muoversi. Non vanno riunite ma riconnesse, fatte riconoscere vicendevolmente. Non nell’ipotesi di costruire in vitro soggetti politici o di raccogliere – ancora? – firme in calce a nuovi Manifesti. Non con l’obiettivo di ridurne le differenze e unicità a forzate quanto instabili identità. Non con la spocchia di possedere in partenza risposte ma con l’urgenza di condividere domande all’altezza dei “tempi interessanti” che stiamo attraversando, intesi nella forma ambivalente di benedizione/maledizione che deriva dalla tradizione cinese.
Se queste non fossero le premesse fondative di questo viaggio che fa della solitudine un motivo di necessaria attivazione, quella che stiamo vedendo dispiegarsi scompostamente attorno a noi potrebbe addirittura apparirci come una fase di rinnovamento della geografia politica. Ma la moltiplicazione di partiti, partitini e movimenti unita alla frenesia che attanaglia la scalcagnata classe politica italiana (perché sempre di manovre tutte interne agli addetti ai lavori si tratta) rischia di essere il tossico rimasuglio di un inverno lungo e rigido dal quale fatichiamo ad uscire.
La cosa che sembra sfuggire ai più è che il problema non sta nel contenitore, quasi si confondesse un partito con un circolo tennis o un centro commerciale che deve incrociare, in termini di marketing politico, i desideri e i gusti di “pezzi di società” alla ricerca di un nuovo prodotto da acquistare e nel quale riconoscersi. Ognuno degli esperimenti – frutto di scissioni imminenti, di fusioni frettolose, di pruriti identitari – che in queste settimane animano la cronaca e i retroscena giornalistici assomigliano a esercizi di stile (spesso del tutto autoreferenziali) piuttosto che processi di riaffermazione del ruolo della politica. Una dicotomia decisiva, letale, apparentemente insanabili.
Il viaggio che abbiamo in mente non é quello che altri condurranno esponendo le proprie tesi congressuali. Preferiamo il dubbio alle certezze e non ci spaventa la categoria del tradimento. Non sarà nemmeno il filo rosso che tiene insieme la geografia della paura e del rancore (che ha già numerosi interpreti) o quella delle emergenze e degli interessi particolare (anche questa sufficientemente rappresentata). A questi schemi preferiamo i tempi lunghi, magari non del tutto a ritmo con la frenesia dell’attualità, e la complessità.
E’ un percorso che non si dà un termine preciso e questa indeterminatezza – apparentemente sconveniente, addirittura pericolosa in un tempo nel quale sembra obbligatorio annunciare in partenza il proprio posizionamento e la propria traiettoria, i propri riferimenti e i propri nemici – è per il momento una garanzia di libertà, autonomia, non dipendenza. La radicalità sarà una delle chiavi di lettura necessarie, non in quanto mera enunciazione di propositi ma come sperimentazione di alterità all’esistente, inteso come conservazione di una serie di paradigmi che oggi contribuiscono a definire il concetto di stabilità e di non alternativa possibile.
Non è un caso che nel primo “sopralluogo” per immaginare un itinerario capace di coinvolgere il nord-ovest italiano ci sia capitato di passare la mattina a discutere di terre alte e aree interne, di trasformazione dei modelli produttivi, di nuovi paradigmi dello sviluppo nella casa e tra gli scaffali che ospitano l’archivio di Piero Gobetti e di bere un caffè in uno spazio di co-working a poche centinaia di metri di distanza parlando di progetti di riqualificazione urbana a base culturale e di ecosistemi innovativi nel meridione, tra Europa e Mediterraneo. Non contenti abbiamo concluso la nostra esplorazione piemontese spingendoci fino a Ivrea, lì dove Adriano Olivetti sperimentò un modello di relazione tra fabbrica e comunità, tra tecnologia e cultura, tra imprenditoria e inclusione sociale. Un’ipotesi che mantiene ancora oggi – nonostante la malinconica condizione di generale dimenticanza del lascito olivettiano – tratti di incredibile modernità.
Sifr (zero, nella lingua araba) è questo. Il tentativo di trovare compagni di viaggio curiosi e disponibili a mettersi in gioco. La speranza di riuscire a introdurre nella stanca condizione della politica uno o più elementi – così come avvenne con la comparsa del numero 0 – capaci di sparigliare le carte e di offrire lo spunto per una nuova prassi della politica, a ogni livello. Pronti, attenti, via.